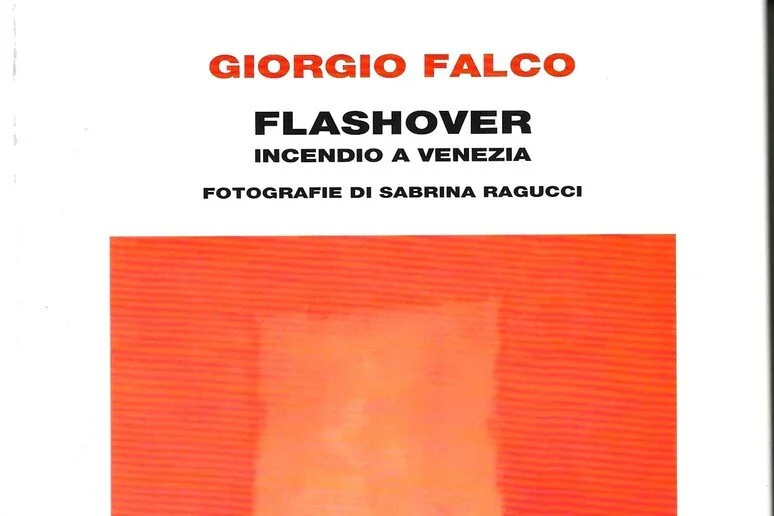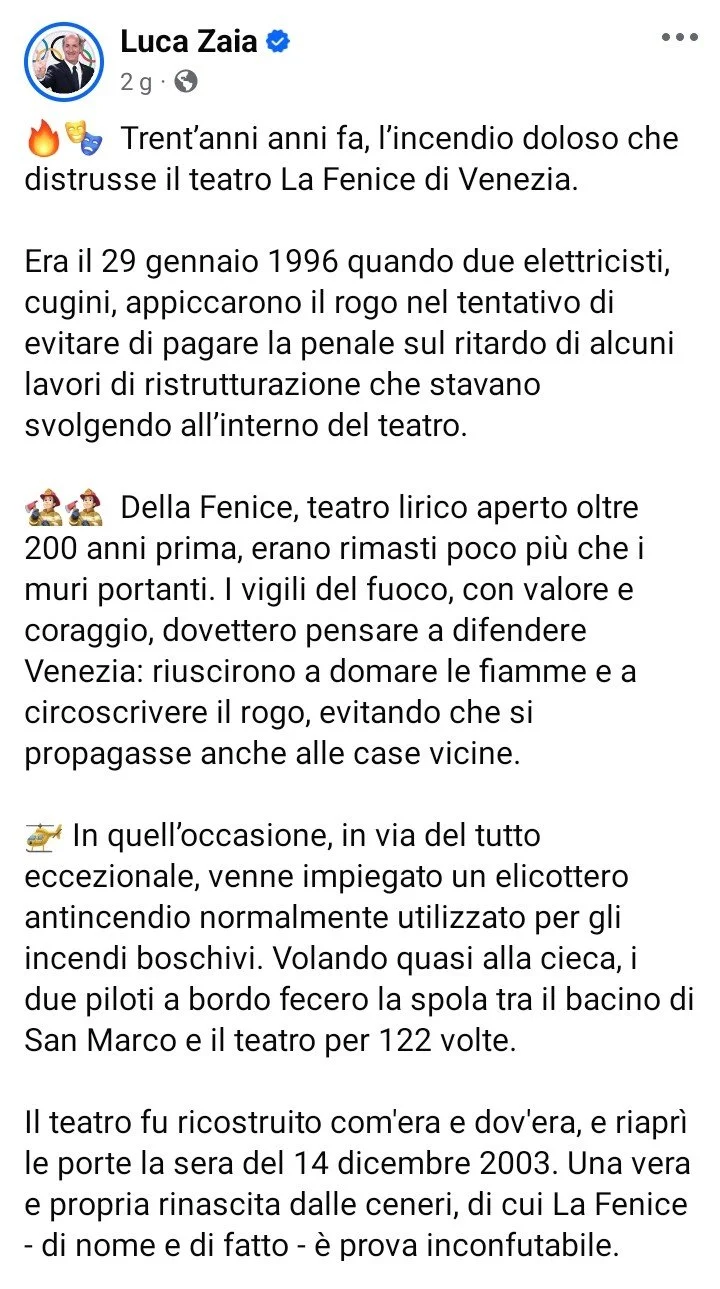Trent’anni dall’incendio della Fenice
C’era una volta un ragazzo che, a differenza di me, viveva a Venezia ed era un piccolo imprenditore. Suo padre era un imprenditore più grande, aveva vinto l’appalto per rifare gli impianti elettrici del Teatro La Fenice, e fece in modo che l’appalto andasse al figlio. Questo figlio, questo ragazzo, si chiamava Enrico Carella, e aveva già qualche debito, ma gli piaceva fare la bella vita. Gli piaceva spendere nei locali, gli piaceva stare in cantiere coi mocassini eleganti, e come prima cosa, dopo aver ricevuto l’appalto, si comprò una Bmw.
L’appalto della Fenice aveva una scadenza tassativa: 28 febbraio 1996. Il giorno dopo, in teatro, si sarebbe esibito Woody Allen con la sua orchestra. Per ogni giorno di ritardo, l’azienda avrebbe dovuto pagare una penale di duecentocinquantamila lire. Sembra poco, vero? Lo so, ma c’era ancora la lira, le banche prestavano soldi a tutti, comprare casa non costava niente, avevamo il campionato più bello del mondo, “Benigni era ancora Benigni” ed era appena cominciato un nuovo miracolo italiano. Erano trent’anni fa esatti.
I debiti di Enrico Carella si accumulavano, e il cantiere era in ritardo. Si fece dare dei soldi dalla compagna, e poi dalla famiglia della compagna, in tutto parecchi milioni di lire; li spendeva poi in cene, vestiti, serate, non li restituì mai, e intanto crescevano i debiti, e cresceva il ritardo del cantiere. Quando capì che non avrebbe mai finito il lavoro in tempo, decise di dare fuoco al teatro. La sera 29 gennaio 1996, per appiccare l’incendio, usò un solvente non suo e il cannello a gas: pensava che, così, sarebbe sembrato l’errore di un’altra ditta. Subito dopo, andò con il cugino Massimiliano Marchetti, suo complice, per una serata a base di birra e hashish. Nel 2003, dopo essere stato scoperto e condannato a 7 anni di carcere, fuggì in Sudamerica. L’Interpol lo trovò a Cancun, in Messico, nel 2007. Approfittando dell’indulto di tre anni, e della richiesta dei servizi sociali, ha passato in carcere, in tutto, pochi mesi.
L’incendio del teatro la Fenice, Venezia, 29 gennaio 1996 (Ansa)
C’è un libro di Giorgio Falco che racconta l’incendio della Fenice, si chiama Flashover. L’autore ha detto di aver strutturato il libro seguendo l’andamento di un incendio. Ogni incendio si divide in quattro fasi: ignizione, propagazione, flashover, decadimento finale. Il flashover, la terza fase, nel gergo tecnico dei pompieri di tutto il mondo, indica lo sviluppo completo dell’incendio, quando la temperatura è altissima, uniforme, e la diffusione è al suo picco. Durante il flashover tutti i singoli elementi bruciano all’unisono, il fuoco è ovunque, ogni cosa non è più come appariva pochi minuti prima, è solo fuoco.
Nel libro c’è un paragone tra l’incendio della Fenice e quello del Padiglione d’oro dell’omonimo romanzo di Mishima, in cui il novizio, Hayashi Yōken, protagonista della vicenda, dà fuoco all’edificio contenente le reliquie di Buddha perché, a differenza del padre, non vuole intraprendere la carriera spirituale.
Enrico Carella e Hayashi Yoken, poco più che ventenni, sono entrambi incoraggiati dai loro padri a intraprendere le rispettive attività: diventare imprenditore e diventare monaco. Entrambi useranno il fuoco (anche) per sopprimere la propria sorte designata.
Cito una parte del libro che mi è piaciuta particolarmente:
“Proprio l'assenza di consapevolezza da parte dei colpevoli rende l'incendio della Fenice soltanto un rogo doloso, e non una delle più grandi performance del Novecento.
Se i due cugini avessero dichiarato la valenza artistica e politica dell'incendio, a tal punto da disinteressarsi delle conseguenze penali del loro gesto, allora sarebbero stati artisti innovativi: altro che i “grandi poeti incendiari” di Marinetti. Ma avrebbero dovuto abbandonare la condizione di padrone e dipendente e unirsi in un nome: Flashover, parola neutra, tecnica, adatta anche al nome di un'azienda. Dietro Flashover potrebbero esserci due, cinque, dieci persone, chiunque. Flashover avrebbe dovuto scrivere un manifesto, lasciarlo in una delle poche cabine telefoniche rimaste e contattare la redazione di un quotidiano per rivendicare l'azione. Questo manifesto sarebbe stato analizzato e interpretato dalla Digos, banalizzato dai media, provocando lo “sdegno unanime di tutte le forze politiche compatte nella ferma condanna”, e poi “la rabbia della gente” di fronte al crimine artistico. Flashover sarebbe stato equiparato alla sigla di un gruppo terroristico. Allora lo Stato italiano sarebbe diventato efficiente e davvero repressivo, avrebbe trovato subito i colpevoli, gli artisti terroristi, fino alla “condanna esemplare”.”
Per uno scherzo della sorte, la notte del 29 gennaio 1996, mentre il teatro stava bruciando, i pompieri combatterono contro il fuoco in una città fondata sull’acqua, ma attorno alla Fenice mancava proprio l’acqua: i canali erano in secca a causa della bassa marea.
Il presidente della commissione Cultura della Camera Vittorio Sgarbi annunciò che il magistrato incaricato avrebbe dovuto procedere senza cercare tracce dolose, che avrebbero rallentato i lavori di ricostruzione.
Il magistrato Felice Casson, invece, operò in modo diverso.
Dieci anni prima si era occupato delle indagini sulla Strage di Peteano: nel 1972, in provincia di Gorizia, era stata segnalata un’auto sospetta, i carabinieri erano giunti sul posto, e quando avevano provato ad aprire il cofano la macchina era esplosa. Tre carabinieri morti, due gravemente feriti.
Quando i carabinieri si chiamavano “militi”
L’autobomba era stata allestita dai neofascisti Vincenzo Vinciguerra, Carlo Cicuttini (dirigente del MSI) e Ivano Boccaccio.
Giorgio Almirante (nella vostra città magari avete una via con questo nome) trovò trentacinquemila dollari per far espatriare Cicuttini nella Spagna franchista e cambiargli identità tramite un’operazione alle corde vocali.
Almirante fu condannato per favoreggiamento aggravato verso terroristi neofascisti, poi salvato grazie all’immunità parlamentare e alla successiva amnistia, ma questa, come si dice, è un’altra storia.
In questi giorni, vista la ricorrenza dei trent’anni, sono stati pubblicati molti articoli sull’incendio della Fenice. Alcuni si concentrano sulla portata simbolica della rinascita dalle ceneri, molti sull’eroismo dei pompieri, la gran parte sull’orgoglio per la ricostruzione del teatro. Quasi nessuno si sofferma sulla storia del colpevole e del suo complice, quasi nessuno cita i loro nomi. L’evento, nei media quanto nell’opinione pubblica, sembra collocarsi esattamente nella comfort zone delle nostre narrazioni, dove le scorie di un avvenimento drammatico (non importa se voluto, o annunciato, o nascosto; non importa se costato come tre finanziarie) vengono lavate via dal peso dell'immaginario (Venezia e il fuoco!), dal chiacchiericcio, dall’emergenza, dall’eroismo, persino da una possibile rivalutazione in chiave retorica: “Vedi che quando ci mettiamo d’impegno…”
Il post “celebrativo” di Luca Zaia, con tanto di emoji del fuoco e faccine dei pompieri.
In conclusione, ancora da Flashover di Giorgio Falco:
“In ogni italiano giace la salma di un povero, ma se l’italiano dimostra di desiderare la ricchezza, avviene il miracolo: la salma del povero resuscita, diventa un ricco vivente, l’italiano imita l’americano, in ogni povero riposa, potenzialmente, un ricco, e allora l’italiano fa l’americano, senza l’affanno dell’apparente integrità protestante”.
La Fenice dopo la ricostruzione e la riapertura, avvenuta nel 2003